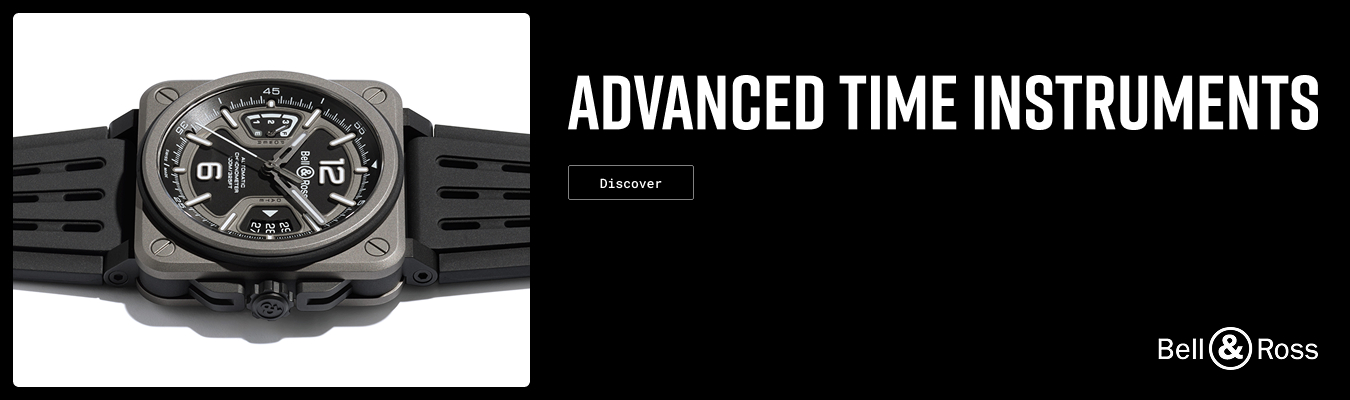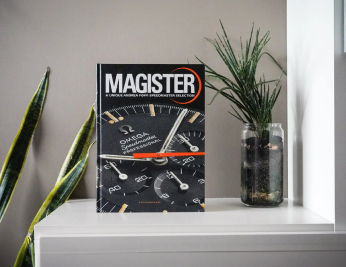L’orologeria, è risaputo essere un settore molto legato alla tradizione e all’abilità tecnica degli orologiai e, nonostante lo sviluppo tecnologico e informatico abbia ormai invaso le nostre abitudini, possiamo notare come gli orologi più venduti e apprezzati siano rimasti quelli meccanici, alimentati da ingranaggi e molle.
Quest’oggi parleremo proprio di questo, ossia, di come si è evoluto il meccanismo interno di un segnatempo, analizzando i diversi movimenti e cercando di capire le principali differenze e peculiarità di ciascuno di essi.
Il movimento meccanico

Il movimento meccanico è la prima tipologia che andiamo ad analizzare quest’oggi, ed è anche il più antico, poiché inizialmente veniva utilizzato nelle torri dei campanili per scandire la quotidianità delle città. Successivamente, è stato miniaturizzato sempre di più e posizionato all’interno degli orologi da tasca prima, e, successivamente, in quelli da polso. Il funzionamento di questo movimento, all’apparenza risulta molto semplice, ma il suo perfezionamento ha richiesto diversi secoli di studio.
Il funzionamento del movimento meccanico
Parlando di movimento meccanico bisogna fare, prima di tutto, una distinzione nel modo con cui può essere caricato l’orologio. Infatti, parliamo di carica manuale quando la molla di carica viene compressa solamente ruotando la corona a ore 3, mentre con carica automatica si intende l’alimentazione del movimento anche tramite il movimento del polso, grazie ad una massa oscillante posizionata sul movimento.

La fase di azionamento inizia con il bariletto, ossia un contenitore all’interno del quale troviamo la molla di carica. Quando carichiamo il nostro orologio girando la corona ad ore 3, nel caso di un calibro a carica manuale, o attraverso il movimento del polso che aziona la massa oscillante, stiamo di fatto arrotolando questa molla che immagazzina energia potenziale elastica, la quale verrà rilasciata piano piano trasformandosi in energia cinetica, grazie al bilanciere (ruota oro nella foto successiva) che ne regola lo scaricamento.

La molla all’interno del bariletto, attraverso un treno di ingranaggi, traferisce quindi la forza al bilanciere, il quale ruoterà a destra e sinistra in modo bilanciato e alternato grazie ad una spirale integrata ad esso. Al bilanciere è attaccato un componente chiamato ancora (pezzo a forma di T nella foto sopra), la quale interagisce con la ruota di scappamento (ruota in viola nella foto superiore) permettendo all’energia di essere rilasciata in modo regolare. Questo processo è ciò che produce il caratteristico “tic-tac” dell’orologio. Ogni oscillazione del bilanciere permette al ruotismo di avanzare di un dente, trasformando l’energia potenziale della molla in movimento regolato.
Avete presente le alternanze/ora presenti nelle schede tecniche degli orologi? Ecco, queste indicano la frequenza con qui il bilanciere si muove, per cui un’alternanza di 28.800 alternanze/ora, significa che il bilanciere si muove, a destra e sinistra, circa 28 mila volte all’ora.

Attraverso il “treno del tempo”, ossia, una serie di ingranaggi che collega il bariletto alla ruota dei secondi, dei minuti e delle ore, l’energia viene distribuita e la velocità delle ruote viene ridotta. Poiché la ruota dei secondi compie un giro ogni minuto, il rapporto di riduzione deve essere tale da far compiere alla ruota dei minuti un giro completo ogni 60 minuti (1 ora).
Supponiamo che la ruota dei secondi abbia 60 denti e che la ruota collegata all’albero dei minuti abbia 10 denti. Il rapporto sarà 60:10 = 6:1. Questo significa che per ogni 6 giri della ruota dei secondi, la ruota dei minuti compie un giro. Allo stesso modo la ruota delle ore è collegata alla ruota dei minuti attraverso un rapporto 12:1, in modo che compia un giro completo ogni 12 ore.
La massa oscillante di un movimento meccanico

E’ importante citare la massa oscillante in quanto è stata una rivoluzione cruciale e, guardando i movimenti delle maison più blasonate, notiamo che questa molto spesso è realizzata in oro: perché?
Quando si parla, ad esempio di Patek Philippe, questo aspetto balza subito all’occhio guardando il fondello, poiché la cura del dettaglio è quello che caratterizza la maison di Ginevra. Il tutto si basa su alcuni concetti fisici, come il fatto che l’oro è più denso del comune acciaio di circa 3 volte.
Questo fa sì che la massa oscillante accumuli più energia cinetica quando si muove. In altre parole, quando il polso si muove, la massa in oro ha una maggiore inerzia e può ruotare con più forza, trasferendo quindi più energia al sistema di carica dell’orologio. Inoltre, questa maggiore pesantezza permette alla massa di oscillare anche con piccoli movimenti, contribuendo all’efficienza del meccanismo.
Il movimento al quarzo
E’ risaputo che l’orologiera abbia affrontato un periodo di forte crisi, che ha messo a dura prova le maison durante gli anni 70′ del secolo scorso. Questo periodo è denominato crisi del quarzo, poiché l’industria manifatturiera e tradizionale svizzera, dovette scontrarsi con i bassi costi di produzione e l’elevata affidabilità dei movimenti giapponesi alimentati a batteria, che avevano reso l’orologio accessibile a tutti.
Il funzionamento del movimento a quarzo

Se nel movimento meccanico ciò che alimenta il meccanismo è una molla, nel movimento al quarzo troviamo un cristallo di quarzo che, stimolato elettricamente, vibra sempre alla stessa frequenza. Questa vibrazione è visibile tramite la lancetta dei secondi. Spieghiamolo meglio.
Il quarzo è un minerale, il quale ha una proprietà chiamata piezoelettricità, ossia, se stimolato elettricamente, questo inizia a oscillare con una frequenza precisa e stabile. Chiaramente all’interno degli orologi è presenta una piccola quantità di questo materiale, che viene tagliato e modellato in modo da vibrare alla frequenza di 32.768 Hz (oscillazioni al secondo) solitamente.
Per stimolare il cristallo, è necessaria una batteria a tensione costante che permette al quarzo di oscillare continuamente.

Ovviamente la lancetta dei secondi, visibile sul quadrante, non potrà effettuare 32.768 giri al secondo. Entra quindi in gioco il circuito elettrico presente in questo tipo di movimento, il quale divide il segnale per 2 ripetutamente (15 volte) fino a ottenere una frequenza costante di 1 Hz, ossia un impulso al secondo. Questo impulso è inviato a un motore passo-passo, che aziona gli ingranaggi sottostanti al quadrante per far muovere le lancette.
Un aspetto cruciale di questo movimento, è il fatto di non essere influenzato da fattori esterni come temperatura o umidità, per cui, in qualsiasi condizione, il quarzo vibra alla stessa frequenza, rendendo questo tipo di orologi molto affidabili e duraturi nel tempo, senza la necessità di manutenzione come avviene, invece, nei movimenti meccanici.
Il movimento al diapason

Introdotto prima del quarzo, e per la prima volta nel 1960 da Bulova con il modello Accutron, il movimento al diapason è stata la prima alimentazione in alternativa a quella meccanica, caratterizzata da un’elevata affidabilità e precisione.
Questa nuova tipologia di alimentazione, ha riscosso tantissimo successo in quegli anni poiché è stata la prima a dare una nuova soluzione in sostituzione al classico calibro meccanico che, nonostante i notevoli miglioramenti nel corso degli anni, possedeva un notevole scarto giornaliero in termini di precisione.
Il funzionamento del movimento al diapason

Il funzionamento di questo movimento è molto simile a quello al quarzo, infatti, anche in questo caso abbiamo un componente che, stimolato elettricamente, vibra ad una frequenza costante (32.768 Hz).
Sto parlando del diapason, un elemento metallico a forma di “U”, il quale è sollecitato da un campo elettromagnetico prodotto da un elettromagnete alimentato da una batteria. Questa vibrazione viene attenuata e ridotta da un trasduttore, che converte il la vibrazione in impulsi elettrici.
Gli impulsi elettrici generati dal trasduttore vengono inviati ad un motore passo-passo. Questo tipo di motore converte l’energia elettrica in movimento meccanico e fa avanzare gli ingranaggi del treno del tempo, il meccanismo che muove le lancette. In questo caso, il movimento che vedremo sul quadrante, sarà molto simile a quello di un orologio meccanico in quanto la lancetta dei secondi esegue un moto continuo, senza interrompersi.

Le caratteristiche principali di questo movimento sono l’affidabilità e la precisione (lo scarto è irrisorio, si parla di qualche secondo al mese), due peculiarità che lo rendevano diffuso in tutto il mondo, prima dell’arrivo del quarzo.
Il movimento al Quarzo VS Diapason: le differenze
All’apparenza questi due movimenti possono sembrare molto simili ma ci sono diverse caratteristiche che li differenziano.
Nel movimento al quarzo abbiamo visto che è presente un circuito elettrico che riduce la frequenza di oscillazione del minerale, mentre nel movimento al diapason abbiamo un trasduttore, ossia un componente che permette di convertire un tipo di energia in un’altra. Possiamo riassumere dicendo che nel quarzo si riduce la frequenza in modo digitale, mentre nel diapason la si riduce in modo analogico.
Un’altra differenza è il modo in cui le lancette dei secondi “battono” sul quadrante. Infatti, nel primo caso questa si muove ad impulsi di 1 secondo, mentre nel secondo troviamo un movimento lineare, come se l’orologio fosse meccanico.
Negli anni il movimento al quarzo, per i più bassi costi di produzione e semplicità delle componenti, è riuscito ad insinuarsi maggiormente nel mercato, diventando ormai uno standard per la maggior parte degli orologi che non presentano calibri meccanici.
Il movimento Spring Drive
Un altro tipo di alimentazione che ha fatto molto parlare di sé, a causa dell’elevata complessità dal punto di vista ingegneristico, è il movimento Spring Drive, un particolare tipo di movimento brevettato da Grand Seiko che possiamo dire essere un ibrido tra i due appena citati sopra.

Il movimento Spring Drive rappresenta una combinazione unica di tecnologia meccanica tradizionale e regolazione elettronica, che garantisce una precisione superiore a quella degli orologi meccanici convenzionali. Lanciato nel 1999, rappresenta una fusione tra la bellezza e la tradizione degli orologi meccanici e la precisione degli orologi al quarzo, creando un sistema che funziona senza batteria ma con un regolatore al quarzo.
Il funzionamento inizia con una molla motrice, simile a quella degli orologi meccanici, che immagazzina energia e la rilascia gradualmente. Questa energia fa ruotare una serie di ingranaggi ma, invece di usare uno scappamento tradizionale per regolare il movimento, lo Spring Drive utilizza il Tri-Synchro Regulator. Questo sistema controlla tre forme di energia:
- Energia meccanica dalla molla motrice;
- Energia elettrica generata da una bobina magnetica che trasforma il movimento degli ingranaggi in impulsi elettrici;
- Energia elettromagnetica per controllare la velocità della ruota di scappamento mediante un freno elettromagnetico.

L’energia di svolgimento della molla fa muovere il bilanciere, generando elettricità nella bobina che alimenta il cristallo oscillatore ed il circuito integrato. Il circuito integrato confronta la precisione dei segnali elettrici generati dal cristallo oscillatore con la velocità di rotazione del bilanciere, e su questa base controlla la velocità di rotazione del bilanciere applicandovi, ove necessario, il freno elettromagnetico.
E’ proprio questa la cosa più affascinante, ossia il fatto di non avere attriti a livello del bilanciere, rendendo questo tipo di movimento estremamente fluido ed efficiente. Questo processo assicura infatti una precisione estremamente elevata, con una tolleranza di ±1 secondo al giorno.

Uno degli elementi distintivi del movimento Spring Drive è il movimento lineare della lancetta dei secondi. Diversamente dagli orologi meccanici, in cui la lancetta dei secondi si muove a piccoli scatti, la lancetta negli orologi Spring Drive scorre in modo continuo e regolare, senza alcuna interruzione visibile.
Il movimento Spring Drive può essere sia automatico che manuale.
Altri tipi di movimento
Il movimento Solare
Il movimento solare utilizza un pannello fotovoltaico posto sotto il quadrante per convertire la luce (solare o artificiale) in energia elettrica. L’energia viene poi immagazzinata in una batteria ricaricabile, che alimenta l’orologio anche in assenza di luce per periodi prolungati. Questo sistema, come l’Eco-Drive di Citizen, elimina la necessità di sostituire la batteria. È una tecnologia che garantisce grande autonomia ed affidabilità.

Il movimento Kinetic
Il movimento Kinetic, introdotto da Seiko, genera energia attraverso un rotore che si muove con il polso. Il rotore alimenta un generatore che produce elettricità, immagazzinata in una batteria ricaricabile o capacitore. Questo sistema combina la carica automatica, tipica degli orologi meccanici, con la precisione di un movimento al quarzo. Il Kinetic offre autonomia a lungo termine senza richiedere la sostituzione di una batteria convenzionale.

Visita il nostro canale Youtube per vivere il meglio del mondo dell’orologeria in prima persona.
Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale seguici su Instagram.
Fonti
Meccanico:
https://nomos-glashuette.com/it/topics/orologi-selezionati/orologi-meccanici?srsltid=AfmBOorIZMxHXgkBtMySt6giQYZjchzSk2axqMQe2YmR3H8r2A_l7cJk;
Cosa anima un Orologio Automatico? Tipologia e funzionamento della massa oscillante
Quarzo:
https://it.wikipedia.org/wiki/Orologio_al_quarzo
https://www.seikowatches.com/it-it/customerservice/knowledge/quartz-knowledge
Diapason:
https://it.wikipedia.org/wiki/Orologio_a_diapason
https://segnatempo.it/come-e-fatto-un-orologio/diapason/#:~:text=L’oscillazione%20del%20diapason%20è,da%20il%20moto%20all’orologio.
Spring Drive:
https://www.grand-seiko.com/it-it/collections/movement/springdrive; https://www.youtube.com/watch?v=BQ4yxc7EviQ&t=165s&ab_channel=SeikoWatchGlobal
Solare:
https://www.citizen.it/tecnologia-eco-drive
Kinetic:
https://www.seikowatches.com/it-it/customerservice/knowledge/kinetic-knowledge